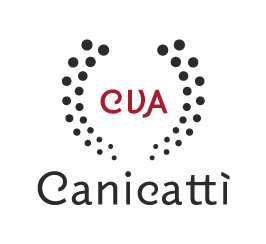La recente deregulation decisa da Zaia (che da ministro dell’agricoltura agiva diversamente) potrebbe avere effetti negativi su immagine e qualità

La vendemmia si avvicina. E buona o cattiva che sia, l’annata 2016 sarà comunque segnata dalla deregulation, sebbene temporanea, sull’utilizzo del marchio del Prosecco doc da parte dei produttori. Una decisione che sul lungo periodo il Veneto potrebbe pagare caro. Fino a quest’anno infatti, l’utilizzo del marchio era riservato ad una platea, non ristrettissima, la cui composizione si deve all’attuale presidente regionale Luca Zaia, che nel 2009 da ministro leghista dell’agricoltura volle fortissimamente che la tutela sul marchio – sul disciplinare, sulle aree geografiche e sulla produzione – seguisse standard ben determinati. Obiettivi: salvaguardare la qualità e soprattutto non inondare il mercato con una bolla produttiva che già da allora preoccupava i viticoltori più coscienziosi, che non vedono di buon occhio il “prosecchificio a buon mercato” adottato da alcuni nella Marca trevigiana e del Vicentino.

A luglio però le cose sono cambiate radicalmente. Dopo avere analizzato i trend del mercato (addirittura con la consulenza di Nomisma, riferisce il GdV) e dopo aver notato che la bollicina veneto-friulana all’estero tira e come, anche perché si starebbe ritagliando il ruolo di killer delle fasce di mercato più basse un tempo detenute dal cugino nobile, il francesissimo Champagne, il Consorzio di tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco ha ingranato la quarta. Come? Sollecitando la giunta a consentire la produzione del famoso vino sparkling. Ovvero consentendo «l’utilizzo straordinario esclusivamente per la vendemmia 2016 delle superfici a uva Glera aventi i requisiti per la produzione della Doc Prosecco». Il Glera altro non è che il vitigno base per la produzione del prosecco. Ora: se si autorizza solo per un anno (sempre che la deroga non sia prorogata sine die) a chiamare prosecco ciò che non é marchiabile come tale, ciò può significare solo due cose: o che partendo da quel vitigno si può sempre ottenere un buon Prosecco, e quindi il marchio altro non è che una tutela prigioniera del marketing; oppure che la qualità del vino cambia effettivamente. E allora il consorzio e la giunta regionale sono complici nell’aver allentato sulla qualità a scapito della quantità per motivi di bassa cassa. Tertium non datur.
Che cosa succederebbe, per esempio, se la Regione Toscana di punto in bianco autorizzasse i viticoltori grossetani dell’Amiata, che pure usano lo stesso vitigno Sangiovese, a chiamare Brunello di Montalcino i pur gagliardi vini prodotti in loco? La stampa italiana, ma soprattutto quella francese in una con quella anglosassone, sparerebbe a palle incatenate. Sarà pure un’ovvietà ma un vino eccellente lo è anche senza una etichetta appiccicata, mentre un’etichetta blasonata non necessariamente fa un vino eccellente.
I viticoltori veneti con la “V” maiuscola sanno bene che un Glera o un Durello (per passare ad un vitigno berico-veronese) prodotto e vinificato come Dio comanda, si fa bere tanto quanto e tanto bene come il vicino di natali friulan trevigiani. Detto in altri termini perché, in nome dell’idea che il brand tiri comunque, con la delibera votata in luglio si accarezza l’idea di una prosecchizzazione del vino veneto, tralasciando il resto? Sullo sfondo c’è il rischio che questa rincorsa al brand condanni l’ottimo Prosecco al ruolo di “Champagne dei poareti” in nome di un business a breve termine che oggi sembra tirare, ma che in futuro, se non saggiamente coltivato, può rotolare per terra.
Ricordiamoci il brutto esempio di Recoaro, già meta di re e filosofi. Ricordiamoci di come l’acquamineralizzazione del luogo e la speculazione edilizia abbiano ridotto la ex conca di smeraldo in una vallata semiabbandonata e incofanata da uno scatolame edilizio cadente e scalcinato.
( Fonte vvox )