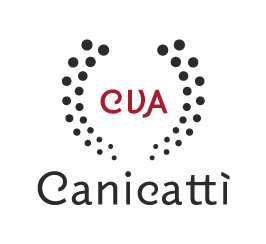Un racconto di Dino Giarrusso, liberamente ispirato a una storia vera

Spaesata, incapace di capire e di capirmi, mi chino a prendere la terra in mano. Mi sembra l’unica cosa da fare. Toccare la terra. Le nostre vigne sono state maltrattate per anni, trascurate, rese tristi dal nostro disinteresse. Ma la terra è sempre quella. E mi pare l’unico punto di contatto reale con la mia storia, a questo punto. Cammino per le vigne della mia famiglia e non so cosa sarà di loro: E con loro, di me. Ma la terra è friabile, morbida. Mi pare abbia tutta la disponibilità ad accogliermi, e forse a raccontarmi. Così ne prendo dapprima un pezzetto in mano, piegandomi sulle ginocchia. Si sbriciola, è tenera. Allora metto dentro alcune dita, e poi tutte: entrambe le mani dentro la terra, fino a metà palmo. E’ ancora abbastanza calda. Mi accoglie, gentile. Non sa dell’uragano che turbina dentro di me, né della mia assoluta incapacità ad affrontarlo. Un’incapacità che mi fa paura: vorrei non essere qui. E allo stesso tempo, non posso che essere qui, non potrei essere da nessun’altra parte al mondo, in questo momento. Alzo la testa, mi guardo attorno e non sembra esserci anima viva. Solo viti affaticate, e più lontano gli ulivi. Rientro in casa, i carabinieri saranno qui a momenti.

Il brigadiere Pappalardo spande l’odore della sua acqua di colonia nell’ampio e vuoto salone che da tanti anni sa solo di chiuso. Ne ha messa troppa, e come chiunque si profumi troppo, certamente non sa di aver esagerato. Il suo pancione bombato rende tesa la stoffa della divisa, tesa in maniera innaturale: una stiratura permanente. Sembra soffrirne, la divisa, come quei muli troppo carichi che fanno pena a guardarli, eppure vanno. Non mi piace, e mi rende subito diffidente. Ha folti peli nel naso, così folti che si fondono coi baffi. Mi chiedo se non si accorga quanto siano sgradevoli, quei peli che escono dal naso, e se quando è entrato nell’arma dei carabinieri avesse già questa pancia enorme. No, mi rispondo. Non era così, Pappalardo, trenta anni fa. Certamente essere di compagnia a Randazzo, avere un “posto sicuro” (sarà mai stato licenziato, un carabiniere? E se sì, sarà stato licenziato per sopraggiunta obesità?), conoscere tutti i paesani, essere in qualche modo temuto e rispettato a priori, lo avevano fatto sedere. Rammollito, ingrassato, soddisfatto. Sicuro che qualunque cosa sarebbe potuta mutare al mondo, ma non la granitica certezza del suo posto di lavoro nel borgo dell’Etna che si piccava compiaciuto di conoscere e -immagino lo pensasse- di controllare in ogni dettaglio. Così poteva permettersi anche di non tagliarsi i peli del naso, poteva riempirsi di profumo anziché lavarsi, poteva portare in giro quella pancia eccessiva, invadente. Sono quasi certa -anzi- debba esser stato indifferente, ove non orgoglioso, nel periodo in cui la vedeva ingigantirsi e renderlo ingombrante. “Mi rispetteranno ancora di più”, mi sorprendo ad immaginare possa aver pensato allora. Mentre lo osservo, mentre mi immagino che vita possa aver fatto quell’uomo che qui oggi rappresenta lo stato, lui parla, parla, parla. E nel flusso indistinto del suo parlare monocorde, distinguo finalmente una domanda: “Signorina, ma quant’ha che in questa casa non c’è più sorveglianza?”.

Sgrammaticato senza sapere d’esserlo, me lo chiede con un sorriso sospeso esattamente a metà fra rimprovero e offerta d’aiuto. Da quando la casa è vuota? Da due anni, credo. Anzi, lo so. Due anni a ottobre: da quando i massari che vivevano qui ci hanno detto che sarebbero andati via. Ma non rispondo subito, perché il tono di quell’uomo, il suo odore, la sua sicumera, mi infastidiscono. E il sorriso che permane mentre prendo tempo, aumenta il mio disagio. Penso che voglia propormi lui dei nuovi custodi, o addirittura una vigilanza privata, armata e pagata. Immagino che dietro quell’ammiccare, quel tono da bonario padrone della zona, ci sia un interesse. E forse sbaglio, esagero. Torno in me e gli rispondo, non prima di essermi rimproverata per quel troppo sospettare. Lui quasi sobbalza. “Ma perché non ci avete avvertito, mi scusi? Almeno passavamo ccanfacci di sera, con le sirene accese… i ladri se sanno che in una casa non c’è nessuno, fanu zzoccu volunu riddi¹ ”. Il suo tono di rimprovero mi infastidisce, ma ha ragione. Perché non li abbiamo avvisati? Per pudore, per vergogna. Perché da due anni io e mamma aspettiamo di capire cosa fare della campagna, della grande casa, del terreno, delle viti, degli ulivi. Ma il tempo non aspetta noi, come non aspetta mai nessuno. Finora i ladri avevano rubato poco e niente, perché in casa non c’era quasi niente: venivano, cercavano, andavano via a mani vuote, e ci sembrava normale. Una volta mamma disse solo: “Mi scoccia pensare che si possano coricare qui”, dove per coricare non intendeva dormire, ma intendeva scopare. Lo sapevamo entrambe, ed io accettavo quel suo pudico aulicismo da vecchia Sicilia, notandone più la delicatezza che l’ipocrisia. Ho chiamato i carabinieri, questa volta, perché i ladri hanno tentato di portarsi via l’antica vasca da bagno larga, coi piedi a zampa di leone, ben saldata al pavimento in cotto. In quella vasca papà aveva fatto il suo bagno bollente come ogni sera che passava qui da solo, a badare alla campagna, come diceva lui. Poi era andato in camera sua, e si stava mettendo del borotalco quando lo ha preso l’infarto. Io avevo 13 anni, e ho immaginato almeno mille volte al giorno -tutti i giorni, per oltre quindici anni della mia vita- papà che esce dalla vasca, arriva nella camera riscaldata dalla stufa che ha acceso appena entrato in casa, apre l’accappatoio e inizia a spargersi il borotalco. La contadina che faceva le pulizie lo ha trovato l’indomani mattina ancora con la confezione di borotalco Roberts accanto: quella grande, antica, di latta foderata con la carta verde stile liberty. Mi sono chiesta mille milioni di volte se si fosse accorto di quanto gli stesse succedendo. E se sì, quanto ha pensato a me, e alla mamma. Cosa avrebbe voluto dirci, cosa avrà pensato di dirci, in quei momenti finali. Tutto mi sarei aspettato a 13 anni, ma non la morte di mio papà, che stava sempre bene. E ho desiderato più di ogni altra cosa parlargli un’altra volta, un’ultima volta, per anni. Anche adesso lo desidero, ma adesso so che non accadrà mai più, non in questa vita almeno. Per tanto tempo, invece, il desiderio era speranza, non solo ideale. Speravo di parlargli ancora, e di chiedergli -almeno- cosa gli avrebbe fatto piacere che io facessi. Della mia vita, certo, ma anche della campagna: dei vigneti, degli uliveti, di quello che aveva curato lui, così diverso da me e mamma, così attaccato a quella terra. Mi preparavo le parole, cambiandone spesso i dettagli, come fosse una possibiiltà concreta che mi sarebbe prima o poi capitata, ed alla quale sarei dovuta arrivare perfettamente preparata. Ed ogni tanto immaginavo pure le risposte, le sue possibili risposte, il suo desiderio di rasserenarmi, il sorriso con cui mi avrebbe ascoltata. Dunque, quando la vasca da cui avevo immaginato mille volte uscire mio padre nudo (non avevo mai visto papà nudo: dunque lo raffiguravo in una nuvola di vapore che ne coprisse il sesso, come in un film italiano degli anni ’70 che duellava con la censura) era stata attaccata e danneggiata da una banda di balordi, decisi di chiamare i carabinieri. Avevano rotto una zampa di leone, col martello, ma non avevano strumenti adatti a schiodarla dal terreno, così non erano riusciti a portarla via. Per rabbia, forse, o per semplice cieco sfregio, una potente martellata sul bordo ne aveva scheggiato in profondità il rivestimento in porcellana, e fatto venir fuori l’anima di metallo scuro. Uno squarcio al fianco, mi sembrava.

Guardo Pappalardo negli occhi, mentre firmo la denuncia e il suo verbale. Mi sorride di nuovo, e di nuovo avverto quel disagio. Nel suo sorriso mi pare di leggere un verdetto di condanna, spietato: lei qui incontrerà solo guai. Ma cosa vorrà, questo Pappalardo? Soldi, favori? Vuole comperare lui la proprietà, o far da sensale a qualcuno della zona che tirerebbe sul prezzo per poi ricompensare lui del grande affare? Forse niente di tutto questo. Forse in quell’approssimazione, in quel persistente aroma di acqua di colonia che da vicino era inquinato da un alito pesante (avrà mangiato zuppa di cipolle, noncurante del fatto che ciò lo avrebbe reso sgradevole al contatto ravvicinato: la sciatteria del brigadiere non era dunque solo grammaticale o fisica, era un tratto distintivo e inconsapevole del suo essere, era il modo in cui era cresciuto, forte e solido, in un universo piccolo e immutabile che lo rispettava e forse lo amava persino, nonostante quella sciatteria), io vedevo soltanto tutte le cose che non mi andavano giù del mondo, e della mia vita, e caricavo quel piccolo uomo di intenzioni maligne che non aveva affatto. Era soltanto il brigadiere dei carabinieri di Randazzo: un antico paese dell’Etna distante dalla città, e per questo diventato “città” suo malgrado, capoluogo simbolico della periferia di una zona periferica della Sicilia, periferia d’Italia.
Da bambina chiedevo a papà: “Quanto è lontana, Randazzo?”. E lui mi spiegava che non era poi così lontana in linea d’aria, ma che c’era il vulcano in mezzo. “Se ci fosse un tunnel andremmo dritti dritti, attraverso il vulcano, da Catania a Randazzo. Ma siccome non c’è, dobbiamo fare il giro, e ci stiamo tanto: sono settanta chilometri”. Faceva con le mani il gesto della circumvallazione dell’Etna, ed il numero 7.
Questo mi piaceva, e allora glielo chiedevo spesso, anche se sapevo già la risposta. Non capivo cosa significasse esattamente in linea d’aria, e immaginavo un aereo che volasse fino a Randazzo. Ma non lo dicevo a papà, perché me ne vergognavo: gli aerei -a quanto ne sapessi- erano per andare a Roma, o a Milano, o in America. Capivo invece l’idea del tunnel, e giacché nel vulcano c’è la lava, ero ben felice che il tunnel non ci fosse: se ci fosse stato saremmo dovuti passare in mezzo alla lava, e dunque vicino ai diavoli che lavoravano col fuoco lì sotto. Perché per me bambina, dentro al vulcano c’erano i diavoli ad armeggiare con la lava, ed era bene non disturbarli. A Randazzo avevamo allora sessanta ettari. L’incredibile eruzione del 1981, riversatasi contrariamente al solito nel versante nord-ovest, ne aveva distrutti ventuno. Noccioli e olivi, soprattutto, ma anche un pezzetto di vigna. Però la lava, la lingua di denso fuoco del vulcano che ci stava arrivando fino in casa, non aveva attraversato il letto del fiume Alcantara (che non aveva dunque formato un lago, grazie a Dio), perché -come guidata da una mano invisibile- aveva deviato, e percorso il lungofiume in parallelo al corso d’acqua, per un chilometro e mezzo. Per papà fu come un segno del destino. Il fiume segna tuttora il confine fra le province di Catania e Messina, e lui vendette tutta la parte messinese, tenendo quella più fertile e più vicina alla casa, quella al di qua del fiume. Decise di lavorare sulla vigna, mantenendo solo una piccola parte a ulivi (ed una -piccolissima- con le dolci pere dell’Etna) e di vendere quell’uva a chi faceva il vino in zona, per rientrare dalle spese a accumulare il denaro sufficiente a ritornare produttore e imbottigliatore. Ci teneva da morire, passava qua notti su notti, in tutte le stagioni. Studiava da solo le sovvenzioni che avrebbe potuto richiedere, la burocrazia, i vantaggi possibili, e il rischio di perdere la piena autonomia decisionale. Mancava poco perché avesse messo da parte il capitale necessario a produrre e imbottigliare in proprio, a fare partire una propria etichetta. Era il 1987, lui aveva deciso di imbottigliare la vendemmia successiva, che però non vide mai. I massari, poi, riuscirono a stento a continuare la produzione senza troppi passivi. Senza papà quella terra non rendeva più: si manteneva, a fatica. Per ben sedici anni, in effetti si mantenne. Da due anni, invece, dormiva. Sola.
Il senso di colpa e di impotenza che avrebbero ricoperto me e la mamma se avessimo venduto la proprietà, ci ha portate a perderli, questi due anni. Abbiamo sospeso il problema, finto di dimenticarcene, in un patto più o meno tacito di rimozione condivisa, ma ora non si può più. La ferita è lì, aperta. Lo sbrego alla vasca è lo sbrego della realtà al nostro desiderio che le cose si possano sistemare da sole. Da oggi so che non potrà più essere così. Mi sento preoccupata, inadeguata, quasi in colpa. E mi sento personalmente addosso il peso di tutta questa terra, queste viti, questo fiume che scorre, questa lava dell’Etna, eterna: è tutto sulle mie spalle. Mamma non ha più né l’età né l’energia per occuparsene. Dunque posso (devo) decidere solo io, se vendere -e tagliare così un pezzo di me- o se trovare un’alternativa. Ma quale? Guardandomi intorno mi chiedo cosa fare, cosa diavolo fare di tutto questo. Aspettare che balordi analfabeti vengano a sradicare la vasca e a scopare le loro amanti in casa nostra, e nel frattempo lasciare morire la terra, o vendere a qualche amico di Pappalardo, o a chiunque altro, per poi vedere che qualcuno senza nome ne raccolga i frutti? Soffro, ecco la verità. Ma si può soffrire per avere qualcosa, quando la maggior parte delle persone che soffrono hanno mancanze, e vorrebbero avere di più? Vorrei che tutto fosse sistemato, le viti curate ed ordinate, il palmento rimesso a posto, le botti pronte, le etichette stampate: vorrei chiudere gli occhi e riaprendoli vedere i contadini che vendemmiano, ed io con gli stivali di gomma ai piedi che ne controllo l’efficienza. Ecco, quando ricomincio a desiderare l’impossibile, come da bambina, mi incupisco, mi sento inadeguata alla vita, alla vita vera. Devo, dovrei, rimanere serena e prendere una decisione razionale. Invece vorrei risolvere tutto con una magia: la mia solita, maledetta scorciatoia mentale. La vigna è lì, trema qualche foglia ad un vento poco convinto, c’è silenzio e ancora un poco di sole. Le piante non pensano –penso- non hanno responsabilità, e non soffrono. Sarà vero?
Osservando un grappolo più maturo degli altri, nero scuro e già mezzo marcito, mi ricordo dell’unica persona cui ho raccontato la mia storia. Al Vinitaly di Verona, mentre prendevo informazioni per la mia tesi di dottorato sulle etichette di vino create dagli artisti. “L’etichetta d’autore come immagine del gusto”: mi pareva un titolo cretino, pretenzioso. Lo avevo scelto io stessa, e come molte delle cose che avevo scelto io mi sembrava grossolana e inadeguata già pochi minuti dopo aver avuto l’agognato sì del professore. “Una di quelle minchiate inutili di cui si occupa chi non ha niente di importante da fare” avrebbe detto Alfredo, ed io avrei certo avuto paura a raccontargli perché -invece- per me fosse importante. Infatti non glielo raccontai mai, non gli dissi proprio del titolo della tesi. Nemmeno quando decidemmo di sposarci, nemmeno quando decidemmo di non sposarci più, a tre giorni dalle nozze, con tutto pronto, comperato, immacolato, inutilmente preparato. Invece al Vinitaly, un enologo che da Acireale aveva girato il mondo (e mietuto successi), Francesco Riso, mi disse che il progetto era interessante. Ed ascoltò avido e attento -dopo avermi chiesto il perché di quella scelta- tre ore di racconto sul mio rapporto col vino, con la mia terra, con ciò che ne aveva fatto mio padre, con ciò che era diventata la terra durante la gestione dei massari (che vendevano l’uva a terzi) e poi durante l’abbandono. Tre ore fittissime, l’ultima delle quali inondata di pianto. Mi invogliò a riprendere in mano la proprietà, e a farla fruttare. Ma solo se non lo avessi sentito come un obbligo, solo se ne avessi avuto veramente voglia. “Senza amore non ha senso fare niente -mi disse ridendo- nemmeno l’amore. E tantomeno il vino”. L’uva cresce ancora, fra questi filari, ma quel grappolo anticipatorio, già mezzo marcio e beccato dagli uccelli, mi racconta di come sia cresciuto senza amore. L’assaggio, valutando con lo sguardo lo stato di conservazione dei filari dimessi. La trovo cattiva, ancora. Troppo forte per i miei gusti. “Esiste l’uva da mangiare e l’uva da spremere. L’uva con cui si fa il vino buono, è uva da spremere”, mi diceva sempre papà. Poi però vedevo che ne mangiava a chili, e sembrava adorarla. Da bambina invece io sognavo che quella sconfinata distesa di viti fosse tutta colma di grappoli d’uva fragola, quella buonissima, di cui avevamo solo mezzo filare, vicino casa, fatto apposta per me. Il filare che non c’era più, adesso. Come non c’erano più tantissime cose che mi erano piaciute, forse perché non c’ero più io bambina. Continuo a mangiare quell’uva, sebbene non mi piaccia. Mando un sms a Francesco Riso, immaginandolo in California, in Francia o in Piemonte, luoghi dove ha i suoi clienti più danarosi. Invece è a Puntalazzo, poco lontano da qui. Mancava da quattro anni: mi sembra una coincidenza surreale. Ma esistono, le coincidenze? Domani verrà da me, credo sia l’unico con cui posso provare a sbrogliare la matassa. O, se andrà male, a impiccarmici.
Francesco stappa la bottiglia del suo cliente come se mi mostrasse la foto di suo figlio. Mi chiede di assaggiarne un sorso (mentre guardi quelle foto ti dicono sempre: “E’ bello il mio bambino?”), lo annusa a lungo, dopo averlo fatto ossigenare in uno dei due calici che ha portato. Non mi dà il tempo di rispondere alla sua domanda implicita, però, perché parte in quarta. “Chiara, c’è una cosa che devi sapere subito. Ed è molto importante. Il vino si fa dalla vigna. Le botti, la barrique, le tecniche di invecchiamento… tutto quello che arriva dopo la vigna, deve essere considerato un di più, un importante completamento. Ma, appunto, viene dopo. Lo senti questo rosso? E’ un vino discreto, ma non potrà mai essere di più. Perché da quella vigna non si può ricavare niente di meglio: né ora, né mai. Il vino, si fa dalla vigna. La terra e le piante, stop. La sola cosa che posso fare per te, ora, è capire cosa potrebbe nascere dalla tua vigna”. La sua sicurezza è persino più evidente che un anno fa. Ma oggi mi pare anche più sincero, paradossalmente meno interessato. Arrivati fra i filari, cammina in lungo e in largo, senza dire niente. Si piega, tocca il terreno, visita le viti. Dopo oltre tre quarti d’ora, si gira finalmente a guardarmi negli occhi. Mi sorride. “Sei fortunata”, dice. Quello è per me il primo momento bello da quando è iniziato il mio conto alla rovescia con la realtà. Dura pochissimo, ma è bello. Sorrido anche io. Poi, dopo pochi secondi, penso a quanto immensa potrebbe essere la distanza da quel “sei fortunata” alla serenità.
“Chiara, la terra è buona. La vigna, è buona. Ma va ripresa in mano. Ci vuole lavoro, tempo, e amore. E anche dei soldi, serve un investimento. L’Etna DOC dev’essere fatto almeno per l’80% da uva Nerello Mascalese, quella che avete sempre coltivato qui, ed è uno dei vini in prospettiva più interessanti d’Italia. Finora è stato considerato meno, perché in pochi rispettavano il disciplinare, perché qui sull’Etna per decenni si è fatto il vino per venderlo fuori dalle porte a mille lire la bottiglia, e sul nome -sulla zona- non c’è stata la stessa attenzione e lo stesso rispetto che c’è per la zona del Chianti, o delle Langhe. Ma ora che si è capito pure qui che il vino fatto con cura può far vincere tanto chi lo fa quanto chi lo beve, le cose stanno cambiando. L’Etna è un’isola nell’isola, l’offerta organolettica che può scaturire da vigne dell’Etna particolarmente fortunate, è straordinaria. In America -e non solo lì- chiamano questa zona “la Borgogna del mediterraneo”, e non sbagliano. C’è un’escursione termica forte, e c’è la grande particolarità di fare un vino di montagna in un posto fortemente assolato. Nessuna vite a questa altitudine prende tanto sole quanto quella che cresce qua, e il sottosuolo a Randazzo è molto ricco d’acqua. In più sei dalla parte giusta del fiume: vedi che di là è giallo e qui è tutto verde? La tua terra si è depositata sopra colate molto antiche, quindi hai la fortuna di avere un substrato ricco senza i difetti della terra lavica troppo giovane. Io sono sicuro che i prossimi anni giocheranno a favore dell’Etna DOC, e chi lavorerà bene sulla vigna farà un buon vino, e lo venderà bene. Si stanno facendo anche delle ricerche sul DNA del Nerello Mascalese per capire se è imparentato col Pinot Noir di Borgogna, o con le uve Nebbiolo, da cui si fa anche il Barolo. C’è un lavoro da fare, un grande lavoro da fare. Ma poi si può fare un grande vino. Non scherzo”. Parla con una convinzione pacata sebbene sia entusiasta. Vuol farmi capire che non è un venditore che tenta di piazzarmi il suo prodotto, e quella pacatezza confidenziale -naturalmente- mi fa dubitare di lui. Mi fa temere sia un atteggiamento calcolato, artefatto. Poi però penso che non avrebbe senso, per uno che sta facendo una carriera così proficua, bruciarsi per fregare me. E questo mi fa sorridere, improvvisamente. “Puoi fare uno studio per farmi capire che investimento ci vorrebbe?” “Non c’è bisogno di uno studio complesso: se prendi un paio di fogli, lo facciamo insieme, subito”.
Mi trasferisco a Randazzo che è già quasi inverno. Il freddo è feroce, la casa abitata più vicina è a sette chilometri, il lavoro da fare immane. Sono sola, sola a siderale distanza dalla vita che ho fatto finora. A distanza siderale da tutto, a dir la verità, e da tutti. Non ho la TV, non ho la connessione internet, passo intere giornate senza parlare, e me ne accorgo a sera, perché il telefono invece ce l’ho, ed ogni sera mamma mi chiede come vada. Sentire la mia stessa voce mentre parlo con lei, talvolta mi sorprende un po’: qui, di norma, sento solo i miei pensieri. Ho venduto gli ulivi ed ho chiesto un prestito in banca presentando il piano finanziario di Francesco. Adesso ho 29 ettari, e tutti a vigneto. Era tutto Nerello Mascalese, dunque oltre a ripiantare e curare l’esistente, ho convertito cinque ettari a Nerello Cappuccio. Avevo proposto di fare il vino dal Nerello Mascalese in purezza, visto che è questo l’uvaggio che dà al vino maggiore complessità, mentre il Nerello Cappuccio serve a dare colore, a fare il rosso più scuro e intenso. “Non possiamo fare un vino un po’ più buono, ma dal colore meno carico?” avevo chiesto a Francesco, e lui mi aveva risposto senza dire nulla, ma producendosi nel sorriso con cui si risponde ai bambini che ti chiedono perché non si può mettere acqua al posto della benzina per fare andare la macchina. Avevo capito. Così, per non fare più la figura della bambina che fa domande sceme, ho deciso di studiare, di fare il corso da sommelier, di capire veramente cosa sia il vino, perché imparando ad amarlo profondamente, ho più possibilità di farlo bene.
La fatica è però mille volte superiore a quanto credessi. Non è solo la distanza, l’isolamento, la solitudine. Non è solo il chiedermi, sfinita, sul letto, se abbia senso questa scommessa. No, è il resto che raddoppia il bruciore della mia nuova vita da vignaiola. Al terzo giorno in cui accendo le stufe, sento un tremendo odore di bruciato, e vedo che il fumo invade la casa. Sembra un incendio, ma non ci sono fiamme. I pompieri arrivano e mi spiegano: ha preso fuoco l’enorme quantità di guano che sta nell’intercapedine fra le volte dei soffitti e il tetto a spiovente. Il cosiddetto tetto morto è pieno di guano secco, e il contatto del tubo caldo della stufa col guano, lo ha acceso: l’incendio c’era, ma non era visibile. Ho rischiato di dare fuoco a casa, e adesso so che dovrò stare senza riscaldamento per tutto l’inverno. Non mi importa. Ho messo un termometro antico da ambiente, che mi racconta come anche in casa spesso la temperatura sia inferiore ai cinque gradi. Mi copro, e ci convivo. Peggio è che ogni mattina alle sei venga svegliata dagli spari dei cacciatori. Esco di casa, ed urlo: “SIETE IN UNA PROPRIETA’ PRIVATA, LA FORESTALE E’ STATA AVVISATA E STA ARRIVANDO”. Mi sentono? Non mi sentono? Le uniche risposte sono nuove raffiche. Non smettono di sparare nemmeno quando arrivano gli operai a lavorare nella vigna, ed io ho il terrore di un incidente. Questo si ripete tutte le sante mattine, con i cacciatori che si dileguano all’arrivo della forestale, e spesso tornano. Un giorno anziché la forestale arriva Pappalardo, e mi dice, sempre con la stessa melliflua incredulità: “Signorina, ma lei qua vive sola? Sola sola? Ma per davvero?” qualche mese qui mi ha temprato, e stavolta gli rispondo sicura: “Vuol trovarmelo lei un compagno?”. Per la prima volta, lo vedo abbassare la testa. Quando parlo con mamma edulcoro i racconti della vita di qui, perché ho paura che lei abbia paura per me. Un giorno, però, al telefono sono quasi afona: ho gridato troppo contro i cacciatori. Mamma arriva la mattina dopo, sul presto. Ha con sé le paste calde, ed un megafono. Così ogni mattina mi sveglio alle cinque e mezza, faccio colazione, e poi passeggio per la proprietà un paio d’ore urlando, cantando, parlando forte dentro al megafono. Voglio far scappare gli animali e i cacciatori, sebbene per ragioni opposte. Un giorno ne incontro uno, di cacciatore, con il fucile basso e la coppola sugli occhi. Mi guarda mentre canto Vedi cara di Guccini al megafono, e scuote la testa, a compatirmi. Credo pensi che io sia pazza. Vado a fare la spesa ogni tre giorni, in paese, ed anche la signora dello spaccio, ha la stessa espressione. Penso che loro pensino di me chissa iè a pazza ca sinni sta ssula doc’assupra². In effetti forse sono pazza. Ma mi sento ogni giorno meglio. La fatica è tremenda, certo, a volte toglie il fiato e punisce la schiena, ma è bilanciata dalla bellezza di ogni singolo passo che vedo fare alla vigna. E poi la vita così ha un ritmo nuovo, a me sconosciuto, e mi sembra che il mio tempo, pieno di cose da fare, ora sia di nuovo prezioso, come quando ero bambina, e non volevo sprecare un minuto. Arriva la neve ma non mi fa passare la voglia di camminare per i vialetti e controllare lo stato delle vigne, poi torna il tepore, poi la violenza delle estati assolate con l’aria immobile, e poi ancora pioggia, problemi, nuovi ostacoli e nuove soluzioni da inventare: la vita -insomma- che si diffonde nella mia terra, e che così riempie densamente la mia, di vita. Ogni tanto quando faccio il bagno caldo passo una mano sullo sbrego della vasca, ed ho un brivido. Inizio a dare anche lezioni di yoga, la mattina alle sei. Si sparge la voce, ho alcuni allievi autoctoni piuttosto “freak”, e dallo sguardo della droghiera rilevo che sono passata nel suo schedario personale da “pazza” a “strega”. Mi piace di più, in effetti, fare la strega. A lei meno: ora mi teme.
La prima vendemmia è una festa, ma non significa ancora vino in bottiglia. Ho comperato tini d’acciaio, e fatto restaurare le botti nostre e di alcuni altri paesani che avevano chiuso i palmenti. Il disciplinare di tutela dell’Etna DOC, risalente al 1968, non consente ancora di dare al vino il nome della contrada, come si usa in Francia e in molte altre zone vinicole. Devo scegliere il nome, dunque, oltre a preparare l’etichetta per le bottiglie. “Gli darò il cognome di papà”, penso. E -dopo un secondo- mi accorgo che è anche il mio cognome. Ma per me, sulle bottiglie, ci sarà il cognome di papà. Ho speso tanto, ma sono disposta a spendere ancora, purché a ideare le etichette sia un’artista. Contatto quello che più mi aveva impressionato all’ultima biennale di Venezia visitata. L’idea gli piace, la richiesta è alta ma sostenibile. Gli mando il vino a Milano, chiedendogli che crei quanto il gusto del mio vino gli suggerisce. Ma lui invia subito un bozzetto via fax, scrivendomi che ha già fatto, e che la sua idea prescinde dal sapore del vino, che non serve assaggiarlo. Trovo il suo scetticismo vagamente triste, materialista, e il bozzetto distante da ciò che mi aspettavo. Nella oceanica mole di lavoro che devo sbrigare, però, non mi ritaglio il tempo per chiedergli di fare altre proposte. E la settimana seguente è lui a chiamarmi dicendo che avevo ragione, e che assaggiandolo gli sono venute diverse idee nuove. Ne è entusiasta: mi farà -allo stesso prezzo- quattro etichette differenti.
Le annate 2007 e 2008 vendono bene, e imparo subito a conoscere il diverso genere di acquirenti: privati, distributori, ristoratori, importatori. L’importatore è il cliente migliore: viene, assaggia, e compera subito grandi quantità, pagando al momento stesso dell’acquisto. Paga meno che il dettagliante e il distributore per l’Italia, ma a me non importa: amo pensare che il mio vino, col cognome di papà, viva anche distante dall’Etna, dall’Italia, dagli abbinamenti classici. Vendo in America, soprattutto, e poi in Giappone, Norvegia, Australia, Canada e Inghilterra. Mi piace immaginare che il mio Etna DOC viva piccole avventure in ristoranti architettonicamente e gastronomicamente ai nostri antipodi. Ogni volta che chiudo una vendita per l’estero, mi sento di viaggiare con lui. Lo immagino sorseggiato insieme ad un piatto di renna (si mangerà, la renna?) o ammazzato da un sushi che chiederebbe altro da bere, lo sento annusato e agitato da yankee di ritorno nei loro Ranch, coi cappelli da cowboy ben calcati in testa, o da pescatori di balene fiaccati da estenuanti viaggi per mare. E mi sento viva, e fortunata.
Il 2009, però, è un disastro. Il vino, fermo nei grandi tini d’acciaio, è praticamente imbevibile. Chiamo Francesco, che arriva dopo due settimane, e prima ancora di assaggiare, sceglie di fare una dettagliata perlustrazione della vigna. “La terra sta bene -mi dice- e l’uva pure”. Il vino, però, conviene anche lui sia imbevibile. Provo a venderlo sfuso, per farne taglio di altri rossi. Sarebbe una disfatta, ma almeno riuscirei a ricavarci qualcosa. Dopo due soli anni non posso certo permettermi di non incassare nulla. Ma tutti i potenziali compratori, dopo aver assaggiato declinano. Non va proprio bene, non si può bere. Francesco mi consiglia di tenerlo fermo: stringere i denti e aspettare l’annata successiva. Immagino i miei denti serrati, bianchi, che piano piano si macchiano del rosso del mio vino, che da dentro la bocca penetra verso fuori nelle fessure fra dente e dente, come fosse sangue. Il mio vino ha ridato vigore al mio sangue, il mio vino non può dissanguarmi, penso. Mi accordo col direttore della banca per un nuovo fido, e tengo -sì- i denti stretti per tutto l’inverno. L’annata 2010 è buona: ricomincio a vendere, e stavolta distribuisco bene anche in Italia. Ristrutturo la casa, e potrei permettermi di impiantare finalmente i termosifoni, ma preferisco di no: credo che la mia sofferenza invernale sia utile a che il vino abbia un sapore più intenso: credo che anche il mio sangue, costretto a circolare più vorticosamente per riscaldarmi, ridia vigore al mio vino.
Nel 2011, quando devo liberare i tini d’acciaio dall’invenduto del 2009, avviene la piccola magia: assaggio ancora il vino di quell’annata disgraziata, e lo trovo buono. Più che buono, a dir la verità. In acciaio, mi sembra impossibile che sia cresciuto così tanto. Chiamo Francesco, ho paura di essere io non in grado di giudicare. Lui ride già al telefono e sentenzia, con la solita leggerezza: “il vino è vivo… ha una vita sua, e può sorprenderti sempre”. Tutti gli assaggiatori confermano: è eccellente, questo 2009. Così lo imbottiglio, ringraziando Dio di non aver trovato compratori quando volevo svenderlo. Nel 2011 si sblocca anche il disciplinare dell’Etna DOC, e finalmente posso dare il nome della contrada al vino che produco. Decido così di riservare il cognome di papà solo alla parte migliore della mia produzione (poche migliaia di bottiglie l’anno), e di dare invece il nome della contrada a tutto il resto. Mi sembra così bello, poter curare tutto il procedimento di produzione, conoscere ogni singolo tralcio, vivere qui ogni ora della mia vita, che quasi mi dispiace andare in giro a fare promozione. Ma è il momento, invece. In America vendo benissimo, e qualche mese fa il New York Times ha dedicato due pagine ai vini dell’Etna, citando anche me, e dedicando dieci righe alla mia storia di produttrice. Così parto, sentendo di lasciare quasi un figlio, e comprendo -ora sì, ora pienamente, proprio nel momento della partenza- l’attaccamento di papà a questa terra. Le sue lunghe notti invernali qui, il sacrificare così tanto tempo e così tante energie a questa passione scomoda, a questo lavoro meraviglioso. Al “Del Posto” di New York, il mitico ristorante di Joe Bastianich, prendo la carta dei vini con la fregola giocosa di una bambina che scarta un regalo. Dio mio… una bottiglia dell’Etna DOC che porta il cognome di papà, qui costa 120 dollari. L’orgoglio mi riempie gli occhi, e non mi abbandona per tutto il resto del viaggio. Torno a casa comprendendo cosa sia la felicità: è sentirmi finalmente viva e risolta, come il vino che faccio. Così decido di fare subito ciò che sognavo da un po’. Riempio la vecchia vasca da bagno del mio vino, duecentosettanta litri. Mi spoglio nuda, e mi ci immergo, finalmente. Non è un ritorno nel liquido amniotico, ma è semmai una fusione con chi mi ha cambiato la vita. Mi abbandono, mi lascio andare giù, così da essere completamente immersa, dalla testa ai piedi. Apro gli occhi, con la curiosità del sub che esplora una grotta, ed ho una bellissima visione rossastra della luce del giorno. Emergo, respiro, mi lecco le labbra. Credo di non essere mai stata così bene come adesso. Prendo il calice che mi sono preparata prima di spogliarmi, e bevo, finalmente. Osservo la bellezza di casa mia, completamente ristrutturata. Solo la vasca è rimasta la stessa. Con quella ferita sul fianco, che mi ricorda -ogni volta che la vedo e la sfioro con le dita- che la vita non regala niente, e piuttosto che prender tempo ed aspettare, bisogna viverla. Vivere, bisogna. Proprio come fa il vino.
( Fonte cucina.corriere.it )